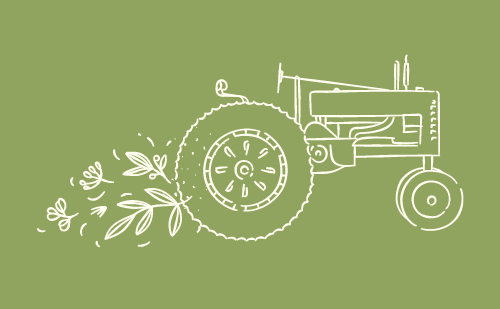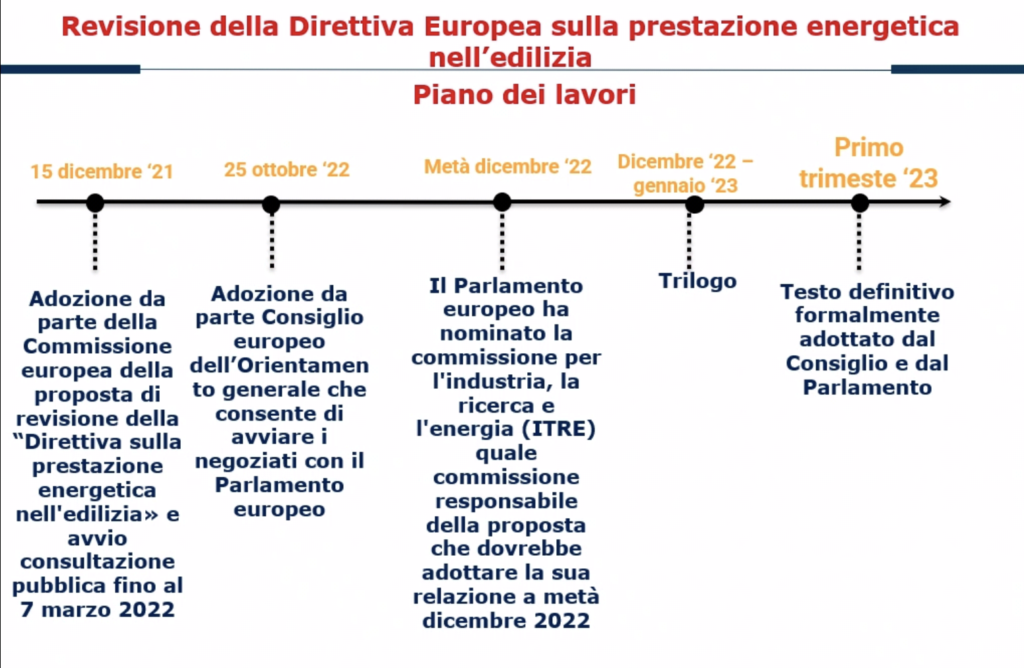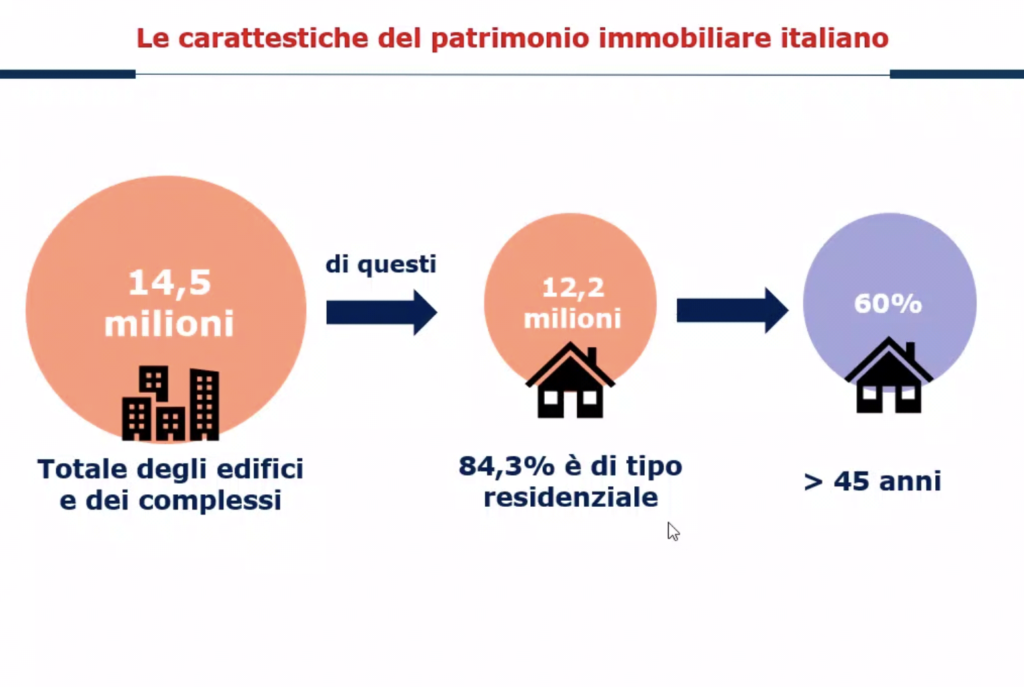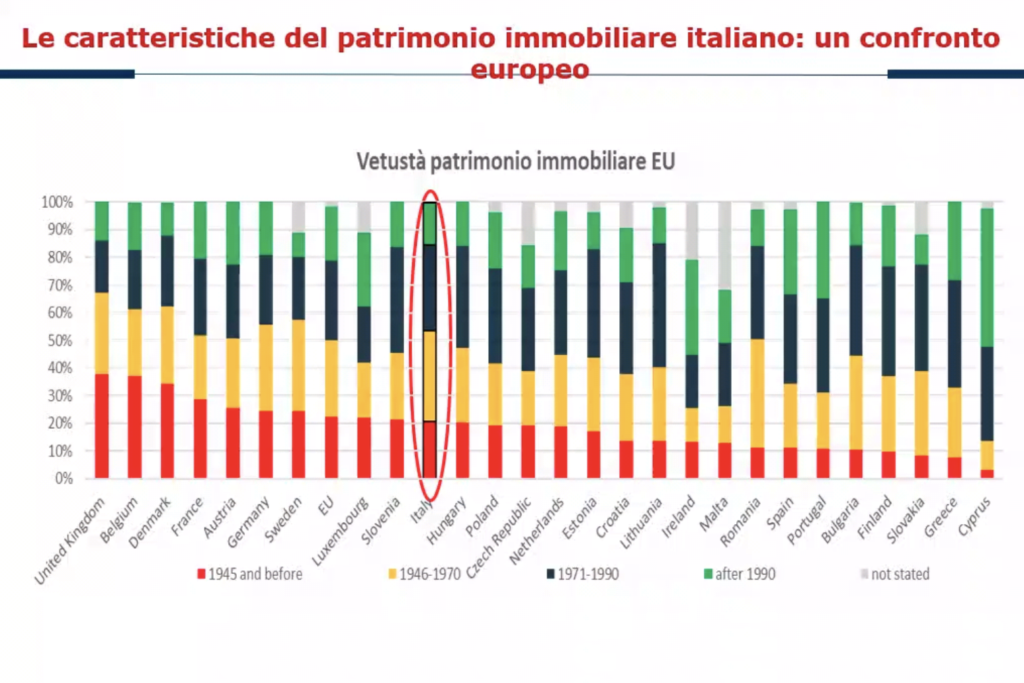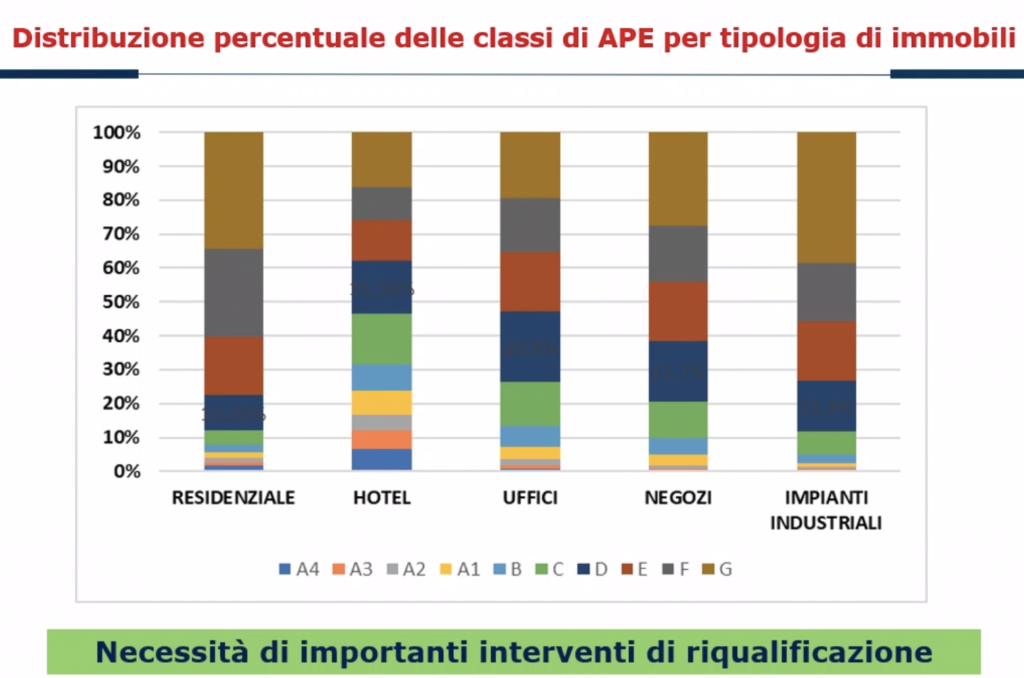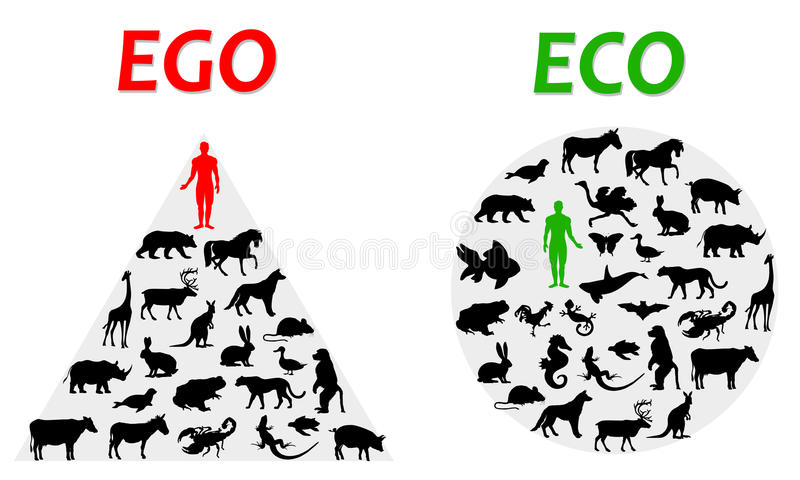A proposito dei trattori
A Proposito dei trattori
con Armando Sarti
Le proteste delle categorie che producono il cibo devono sempre essere ascoltate e attentamente considerate.
Massimo rispetto per chi lavora la terra con passione e alleva animali con rispetto.
I margini di guadagno per gli agricoltori e gli allevatori sono spesso davvero esigui e inaccettabili, soprattutto se si pensa al divario inaccettabile tra quanto spetta ai produttori e quanto poi costa ai consumatori,
dopo tutti gli intermediari dello stoccaggio, trasporto, distribuzione, imballo e consegna ai rivenditori.
Una cosa però non riesco a comprendere.
Com’è che invece di protestare per un sistema di produzione e distribuzione dei prodotti agricoli e di allevamento inadeguati si chiede a gran voce da parte degli agricoltori di bloccare o ritardare, pare con successo già sancito dall’Europa, la riduzione dell’uso dei pesticidi che la Commissione stava finalmente pianificando?
Non è proprio un interesse specifico degli agricoltori e allevatori mantenere un terreno di produzione fertile e sano oltre che preservare sé stessi dai rischi dell’uso esteso dei pesticidi?
Certo la cosiddetta transizione ecologica comporta costi consistenti, ma dovrebbe essere considerata una priorità assoluta sia da parte dei governanti che da parte dei produttori.
E’ noto che ogni stato europeo sovvenziona l’agricoltura ed è proprio alle forme sostenibili di coltivazione e allevamento che dovrebbero essere assegnati gli incentivi in modo prioritario, tanto più quanto più si persegue la produzione biologica, più sana per tutti e molto più sostenibile per l’ambiente.
Certamente servono risorse pubbliche per sostenere lo sforzo produttivo e l’adeguamento necessario per un’agricoltura sana e rigenerativa, ma gli stessi agricoltori e allevatori potrebbero contribuire con pratiche associative sempre più estese, in modo da rivendicare e imporre una giusta retribuzione dei prodotti all’origine, acquisire così più forza contrattuale, anche per arginare la burocrazia asfissiante che logora soprattutto tanti piccoli onesti produttori.
Per questa tematica dell’alimentazione del terzo millennio è bene che nessuno si senta assolto a priori. Noi consumatori abbiamo il potere di scegliere cosa comprare e riorientare così il consumo e quindi la produzione di cibo sano e non dannoso considerando che la qualità ha un costo, sostenibile per tanti solo se si risparmia per altre voci meno cruciali del bilancio economico personale e familiare.